Avere vent’anni: settembre 2004

AMON AMARTH – Fate of Norns
Michele Romani: Gli Amon Amarth hanno un record molto poco invidiabile: sono sicuramente la band più odiata dalla redazione tutta di Metal Skunk. Impietositomi dai soliti disperati tentativi andati a vuoto di Roberto nell’appioppare a qualche poveraccio un loro lavoro per questa rubrica, ho voluto sacrificarmi per la causa e mi sono fatto avanti io. Anche perché penso di essere l’unico dell’intera redazione assieme al Maresciallo Diaz ad avere apprezzato l’Ep d’esordio e il full a seguire Once Sent from the Golden Hall, quando la tamarraggine e il viking da discount ancora non avevano preso piede, e loro sembravano una versione un po’ più melodica e blackettona degli Unleashed. Periodo purtroppo durato veramente poco, perché già dal terzo disco gli Amon Amarth si sono posti l’obbiettivo preciso di fare cagare, commercializzare allo stremo il proprio stile e indirizzarsi ad un target medio di ascoltatori tra i 13 e i 18 anni. Di questo Fate of Norns si salva solo uno dei loro pezzi più noti (The Pursuit of Vikings, ancora oggi eseguita regolarmente in sede live), il resto è un death-viking da osteria noiosissimo di cui non mi ricordo neanche una nota. Il bello è che quelli dopo saranno pure peggio.
SAXON – Lionheart
Stefano Mazza: Dopo un leggero cambio di batterista, che vide l’arrivo di Jörg Michael dagli Stratovarius, i sempre arzilli Saxon uscirono con un album che si collocava nel pieno della loro tradizione, ma con qualche garbata novità. Per esempio la title track Lionheart e Searching for Atlantis hanno un piglio progressive, abbastanza inusuale per il gruppo; Beyond the Grave è radiofonica e dark; Justice e To Live by the Sword sfoggiano un eccezionale lavoro di chitarre ritmiche ad altissima energia; English Man O’War parte come un classico brano NWOBHM ma ha delle variazioni armoniche magistrali, insieme ad assoli che possiamo soltanto definire bellissimi e, infine, la voce di Biff è sempre meravigliosa. La produzione fa suonare il disco un po’ alla tedesca, con chitarre brillanti e dinamiche, la batteria è potente e presente, il basso rimane tragicamente in secondo piano. Insomma, Lionheart è un ennesimo ottimo album di heavy metal classico, che nel 2004 come oggi si rischia di dare per scontato, ma non lo è affatto: un buon album è sempre una cosa importante, quando ci sono musicisti che sanno comporre per davvero è un piacere ascoltarli e chi ama il nostro genere non può evitare di scapocciare almeno un po’ quando sente i Saxon.
ALTER BRIDGE – One Day Remains
Barg: Non credo ci sia bisogno di troppi preamboli, dato che gli Alter Bridge sono, credo, uno dei gruppi di “rock duro” più famosi degli ultimi vent’anni e dato che sin dal principio hanno avuto un ottimo responso sia di pubblico che di critica. Io ero affezionato ai Creed perché interpretavano perfettamente la propria epoca, che poi era quella in cui io avevo vent’anni o giù di lì, e all’inizio gli Alter Bridge mi avevano preso abbastanza bene. Il problema secondo me è la voce di Myles Kennedy, che è un cantante molto bravo, molto dotato, con una buona tecnica vocale e un timbro personale, a cui oggettivamente non si può dire nulla, ma eccessivamente enfatico. Canta ogni canzone sempre allo stesso modo, e cioè con la maggiore enfasi (non trovo un’altra parola) possibile. Dopo un po’ la cosa mi diventa stucchevole. Un pezzo ogni tanto va bene, un disco intero no. Questo debutto è strumentalmente pregevolissimo, ben arrangiato, vario, piacevolmente eterogeneo, dalle atmosfere ora dolci ora ruvide, ora malinconiche ora epiche, ma mi piacerebbe poterlo sentire cantato da qualcun altro, perché dopo dieci minuti inizia a venirmi a noia.
AKITSA – Prophétie Hérétique
Griffar: Al fine di sfruttare in pieno l’enorme hype che i raw blackster canadesi Akitsa avevano fomentato nei primi anni della loro esistenza, grazie a due invero eccellenti full intitolati Goetie e Sangue Nordique (2001 e 2002 rispettivamente), nel 2004 pubblicarono 5 titoli, tutti in formato EP e split 7” e tutti oramai persi nella notte dei tempi in originale, oltre al fatto di essere stramaledettamente blocked-for-sale su quel sito gestito da sinceri democratici di nome Discogs. Parliamo di un titolo solo perché grosse differenze qualitative tra un’uscita e l’altra non ve ne sono; la scelta allora è caduta su uno tra quelli a loro esclusivo nome, il quale tra l’altro contiene il brano Goetie che non figura nel debutto omonimo. La formula degli Akitsa è vincente perché semplice, efficace e di sicuro impatto: una miscela di DarkThrone e Burzum, a tratti incattivita e altrove mantenuta su tempi lenti, sui quali si avvitano riff ipnotici quasi impossibili da schifare per qualunque blackster che si definisca vero appassionato del genere. A questo si aggiunga uno screaming pungente, una scelta di arrangiamenti per i suoni delle chitarre molto distorta, quasi alla francese, e una produzione decisamente ruvida, ed il gioco è fatto: tanti dischi fai e tanti ti verranno comprati, pure a caro prezzo se le tirature sono esigue. Prophétie Hérétique è assai breve, 12 minuti; del resto, essendo un 7’’ EP non si può pretendere chissà cosa. Vale la pena citare dunque gli altri titoli usciti a loro nome quell’anno: Soleil Noir, altro loro prodotto in solitudine da 5 pezzi per quasi mezz’ora di musica, e gli split con Satanic Warmaster, The Shadow Order e Nocternity. Tutto compreso è come un disco intero e pure di discreta durata, buona caccia.
 ANGRA – Temple of Shadows
ANGRA – Temple of Shadows
Cesare Carrozzi: Questo è l’album migliore degli Angra, o almeno lo sarebbe se alla voce ci fosse stato la buonanima di André Matos; non che Edu Falaschi faccia un lavoro men che buono, anzi, ma paragonare Falaschi a Matos (il Matos dell’epoca, dico) è un po’ come mettere a confronto Blaze Bailey e Bruce Dickinson, ovvero uno ce la mette tutta e segna con tanto gioco di squadra, l’altro parte la metà campo, si beve da solo tutti gli avversari e segna lo stesso, e – capite- non è proprio la stessa cosa. Quindi sì, album capolavoro straconsigliato, ma, se dovete scegliere uno ed un solo lavoro degli Angra da portare con voi su un’isola deserta, allora Holy Land rimane sempre l’unica scelta percorribile.

PUNGENT STENCH – Ampeauty
Luca Venturini: Vedendo la copertina di Masters of Moral – Servant of Sin ricordo che mi tornò in mente quando, alle scuole medie, il mitico professore burlone di italiano si presentò vestito da prete, un giorno a caso. Collegai la copertina a quell’episodio pensando a quanto dovessero essere simpatici quei tre metallari conciati da monsignori. L’associazione mentale mi bastò per comprare quel disco. Scoprii un bell’album di death melodico, musica della quale avevo bisogno come l’aria, avendo scoperto l’anno prima At the Gates, Dark Tranquillity, Entombed e la scena svedese cosiddetta. Uscì poi a distanza di tre anni Ampeauty, il quale si discostò molto dal predecessore per approdare a lidi stoner e blues, più vicini a Club Mondo Bizarre” – For Members Only. Il risultato allora non incontrò i miei gusti, ma riascoltandolo per questa recensione devo ammettere che mi sbagliavo. È un disco veramente valido, ha la giusta verve e la presenza di canzoni per lo più mid-tempo amplificano la sua mefiticità. I testi perversi e ironici riprendono gli argomenti cari al trio austriaco e il disco assume una sua forma malata facendo divertire non poco. Se come me lo avevate tralasciato o non l’avevate mai calcolato per andar dietro ad altro, dategli una possibilità. Vale davvero la pena recuperarlo.
METALIUM – As One. Chapter 4
Barg: I Metalium debuttarono nel ’99 e la sensazione generale fu che fossero stati messi insieme dalla casa discografica – la Massacre – per cavalcare il successo del power metal di quegli anni. Le motivazioni erano molteplici, e tutte abbastanza fondate: uscirono fuori dal nulla, senza demo o altro, ma con un battage pubblicitario che un gruppo debuttante si sarebbe potuto tendenzialmente sognare; erano una specie di all-star band, con addirittura Chris Caffery e Mike Terrana in formazione; riprendevano qualsiasi tipo di cliché del genere sia musicalmente che esteticamente. Come si può immaginare, tutta questa sovraesposizione gli fece tanto male quanto bene. Perché alla fine si creò una schiera di gente che li prese in antipatia per partito preso, nonostante poi, tirando le somme, i Metalium fossero un buon gruppo, di sicuro sopra la media di quel periodo. Il problema era che sentirne un disco intero faceva male alle orecchie, per come è quasi tutto velocissimo, epicissimo, carichissimo, con la voce di Henning Basse sempre su tonalità altissime, la batteria in doppio pedale fisso, le chitarre che fischiano, stridono e strillano, eccetera. È tutto esagerato e spinto al limite, anche se non nel senso pagliaccesco che poi venne fuori coi Dragonforce. Per questo i Metalium sono più che altro un gruppo da compilation: ogni tanto te ne senti due o tre pezzi, che ti godi benissimo, e poi hai bisogno di respirare. Se volete provare un estratto da questo quarto album provate Power Strikes the Earth, che vi rifà la pettinatura.
IN BATTLE – Welcome to the Battlefield
Griffar: Nati a metà anni ‘90 per volere di Hakan Sjodin e Otto Wiklund dei Setherial, oltre a due componenti degli Odhinn, gli In Battle hanno pubblicato due dischi di straordinario fast black metal svedese violentissimo, qualcosa che a tratti fa sembrare che i Dark Funeral suonino lentoni da classifica. Recuperateli se non li conoscete perché valgono veramente la pena, se vi piace il fast black con riff glaciali tipicamente scandinavi. Dopo una pausa di sei anni tornarono nel 2004, prima con un EP (Soul Metamorphosis) e poi col terzo album Welcome to the Battlefield. Visto a posteriori, l’EP aveva scopo propedeutico ad avvertire i fan che la musica degli In Battle era in parte cambiata, ora molto più focalizzata a proporre un blackened death ancora brutalmente frenetico, tuttavia meno tipicamente scandinavo e più contaminato dal modo americano di concepire il death metal quando si spinge ai confini del brutal. La tecnica strumentale è senza dubbio mirabile, e viene messa al servizio di composizioni nervose, piene di stacchi, fill, cambi di tempo e situazioni quanto più varie possibile. L’eccellente lavoro fa sì che il disco sia uscito ieri anche se lo ascoltate attraverso quella merda di YouTube, immaginatevi come rende un CD originale in un hi-fi degno di questo nome. Presto spiegato anche il motivo di questo lavorone: l’album uscì per Metal Blade.
NICK CAVE & THE BAD SEEDS – Abattoir Blues / The Lyre of Orpheus
L’Azzeccagarbugli: Il doppio Abattoir Blues / The Lyre of Orpheus è un disco di rottura nella discografia di Cave – come lo saranno anche altri album nel futuro dell’australiano – ed uno dei più sottovalutati della sua carriera. È il primo in cui inizia il sodalizio, tutt’ora in piedi, con Warren Ellis, è un lavoro in cui, proseguendo nell’approccio del precedente e traballante Nocturama, i Bad Seeds tornano protagonisti ed è a tutti gli effetti il lavoro più “solare” mai scritto da Nick Cave. Tacciato, all’uscita, di essere un album eccessivamente pop, in realtà si tratta di un lavoro “corale” (una coralità che, in modo diverso, ritorna anche nell’ultimo, ottimo, Wild God) in cui è il blues – a volte molto “sporco”, altre meno – a farla da padrone, soprattutto in Abattoir Blues, in brani come Hiding all Away e Let the Bells Ring o nella splendida ballata Cannibal’s Hymn, mentre il vero e proprio “pop” si registra solo nei riuscitissimi singoli Nature Boy, Breathless e There She Goes, My Beautiful World. A una certa solarità si contrappongono brani sì ritmati, o molto “orecchiabili”, ma connotati da una certa cupezza di fondo, presenti soprattutto in The Lyre of Orpheus, come la trascinante Supernaturally, la lasciva Babe, You Turn Me On e la conclusiva doppietta Carry Me / O Children, tra gli episodi di maggiore spessore di un album estremamente riuscito che meritava, e meriterebbe ancora oggi, maggiore considerazione.
TIERRA SANTA – Apocalipsis
Barg: Ciccio mi regalò questo disco dopo un viaggio a Madrid, raccontandomi un aneddoto che né io né lui ci siamo mai riusciti a spiegare. Pare infatti che, al momento di chiedere l’ultimo dei Tierra Santa, il commesso del negozio di dischi madrileno abbia fatto una faccia schifata, guardandolo come se gli avesse chiesto, non so, il disco di canzoni di Natale di Gigi D’Alessio. La cosa è strana sia perché di solito gli spagnoli sono abbastanza sciovinisti sia perché, onestamente, non è che il Paese iberico offra tanto di meglio, in questo genere. Con buona pace del suddetto commesso, Apocalipsis invece è proprio un gran bel dischetto, pieno di belle canzoni e con almeno tre-quattro pezzoni spettacolari, come Neron, Kamikaze, Rumbo a las Estrellas (che sembra un omaggio a Jump dei Van Halen) e Sonar con Ella. È tendenzialmente più morbido del precedente Indomable, che era più epico e pompato, e molto diverso dall’ancora precedente Sangre de Reyes, un atto d’amore verso i Maiden di Somewhere in Time; nonostante tutto, Kamikaze è forse il loro pezzo più violento di sempre. Apocalipsis è l’ultimo vero bel disco dei Tierra Santa, che successivamente avrebbero perso la bussola abbastanza in fretta. In conclusione, momento misheard lyrics: al minuto 2.20 di La Ira del Cielo sembra che dica “vorrei scacare el fuego del sol” e dopo vent’anni io ogni volta ancora rido.
ANHKREHG – Against you All…
Griffar: Nati nel 1993, i canadesi Anhkrehg sono stati un oggetto misterioso almeno fino al 2000, quando una piccolissima etichetta canadese (la Frowz) pubblicò quel purulento ammasso di cadaveri marcescenti su un campo di battaglia messo in musica appropriatamente intitolato Lands of War. Un disco ai vertici del war black metal, una badilata in faccia da neanche mezz’ora rimasto quasi del tutto sconosciuto per via di una distribuzione meno che deficitaria. Per anni ricercatissimo grazie a svariate recensioni positive (una anche mia, ma non la trovo più), oggi viene venduto a pochi spiccioli. Quattro anni dopo uscì il terzo e ultimo album Against you All, pure questo una mazzata allucinante che non presenta cali di tensione, pur essendo notevolmente più lungo e con composizioni maggiormente studiate e curate. Addirittura due dei dieci brani sforano la soglia dei sei minuti, che per un gruppo war black metal sono quasi un’eresia, un disconoscimento della loro Vera Fede. Il mondo è piccolo, è molto cattivo ed è popolato da troppa gente: meglio risolvere le cose con della sana insensata violenza, andrà tutto a posto. Riff asciutti, vagamente striati di strane melodie, ritmi in prevalenza forsennati, screaming penetrante senza scadere nel ridicolo, grinta, grinta e ancora grinta. Erano dei grandi, gli Anhkrehg: chitarra, basso, batteria, voce, rabbia e furore. Peccato si siano sciolti l’anno dopo. Solo il batterista Ben ha continuato con la musica, facendo il Dj di musica elettronica. Ma pensa te…
THE CROWN – Crowned Unholy
Luca Bonetta: Francamente non ho mai capito né mai capirò che necessità ci fosse di riregistrare Crowned in Terror. Quel disco è, dopo Deathrace King, il migliore mai composto dalla band svedese; che fino a quel momento non aveva praticamente sbagliato un colpo. Posso comprendere che dopo lo scazzo con Linstrand e la successiva riappacificazione volessero in qualche modo mettere un punto e ripartire; e avrei capito il desiderio di registrare di nuovo quel disco se fosse venuto male, magari con un cantante che non era in grado di rendere giustizia al suono della Corona. Peccato che il sostituto di Lindstrand su Crowned in Terror fosse Tompa, non propriamente il primo stronzo passato di là quanto, piuttosto uno che il death melodico lo ha fondamentalmente creato. Crowned Unholy non aggiunge nulla alla bellezza del suo predecessore, anzi secondo me toglie pure qualcosa: il ritornello cantato in pulito di The Speed of Darkness leva parecchia incisività al pezzo, là dove la versione di Tompa era invece un capolavoro e una delle mie canzoni preferite di sempre. Pure l’intro del disco è scialba rispetto all’originale. Fossi stato in Tompa mi sarei giusto un filo incazzato, ma tant’è. A meno che non siate collezionisti compulsivi potete serenamente fare a meno di questo disco. Crowned in Terror invece va acquistato in copia multipla, a monito di una delle band (un tempo, sigh) più grandi nella storia del metal.
AUTUMN – Summer’s End
Barg: Gli Autumn sono un gruppo a me molto caro nella loro seconda incarnazione, quella con Marjan Velman alla voce, quando virarono su un gothic rock raffinato ed evocativo, riuscendo là dove i connazionali The Gathering fallirono al momento di provare un’evoluzione credibile a quanto fatto nei primi dischi con Anneke. Summer’s End attiene però alla prima fase degli Autumn, quando alla voce c’era Nienke de Jong e il suono era ancora abbastanza legato ad un gothic metal dalle sfumature sinfoniche in pieno stile olandese, sì peculiare ma non troppo incisivo. Il disco non è male in sé, ma purtroppo l’ho ascoltato dopo aver consumato il bellissimo Altitude del 2009, e quindi i paragoni sono stati inevitabili e impietosi. Risentito a mente fresca, questa seconda prova del gruppo di Groningen svela alcuni passaggi interessanti e anche canzoni abbastanza pregevoli, come Gallery of Reality. Però dura quasi un’ora, ed è davvero troppo, tenendo conto dei suoi difetti e delle sue molte ingenuità.
TOTENBURG – Pestpogrom
Griffar: Low-fi, grezzi, strumentisti di livello appena sufficiente, i tedeschi Totenburg, nati nel 1998, nel 2004 pubblicano questo terzo album in una carriera che perdura tutt’oggi, impostata fin dagli inizi a creare un equilibrio tra il black metal più ortodosso e il RAC. Dieci i brani presenti (più una intro wagneriana che non serve assolutamente a nulla, nemmeno ad allungare il disco che durerebbe comunque 50 minuti), quasi tutti di durata medio bassa. Ciò è benefico, perché fondamentalmente il loro schema compositivo è sempre uguale: si parte a canna di fucile, si rallenta, si ripete il riff velocizzandolo per poi tornare a canna di fucile. Non che vada male, ma se cercate diversificazione compositiva o soluzioni estemporanee non è in Pestpogrom che ne troverete. È un disco che può piacere a chi predilige il black metal quando picchia duro e basta, senza tanti fronzoli e dall’attitudine hardcore. I riff sono scarni, sanno di già sentito milioni di volte tuttavia insospettatamente funzionano, quantomeno in questo contesto. Altrove, sinceramente, non penso proprio. Il problema maggiore di Pestpogrom è proprio il fatto che i pezzi finiscono per somigliarsi in modo assai smaccato, solo i due più lunghi ambiscono a distaccarsi dal resto delle composizioni, tuttavia ribadisco che non è la diversificazione compositiva il loro forte. Visto il loro appartenere al mondo NSBM, sono tenuti ovviamente (??) ai margini del mercato, quindi se vi stuzzica l’idea di recuperare il disco non saprei dove consigliarvi di cercarlo.
AGALLOCH / NEST – Split
Barg: Durante gli anni Duemila gli Agalloch, oltre ai full ufficiali, produssero varie piccole uscite. Nello specifico si parla di quattro Ep e di questo split con i finlandesi Nest, un gruppo neofolk che parrebbe essere tuttora in attività. Una canzone a testa per dieci minuti appena: per gli Agalloch c’è The Wolves of Timberline, un pezzo acustico strumentale le cui atmosfere riprendono quelle del capolavoro The Mantle, uscito due anni prima; il contributo dei Nest si chiama invece Last Vestige of Old Joy, anche questo acustico ma più spostato sul versante neofolk, cantato proprio da John Haughm. Entrambe le tracce sarebbero perfette se inserite come bonus in qualche ristampa di The Mantle, e non credo ci sia complimento migliore che si possa fare.
SHAPE OF DESPAIR – Illusion’s Play
Michele Romani: Lo so che per molti fan accaniti degli Shape of Despair questa suonerà come una specie di bestemmia, ma questo è il mio disco preferito della band finlandese. È un lavoro che ha fatto molto discutere per un certo ammorbidimento del suono, e sicuramente l’unico disco di estrazione più prettamente gothic doom che funeral doom, anche se il marchio tipico degli Shape of Despair si sente lontano un miglio. Quest’aura un po’ più malinconica e meno funerea che si respira tra i solchi di questi sei lunghissimi brani dà infatti un tocco meno monolitico e più armonioso al tutto, complice anche l’ospitata di Pasi Koskinen alla voce (ai tempi ancora marito dell’attuale cantante Natalie Koskinen) che è la vera marcia in più di questo lavoro, specialmente nella meravigliosa traccia d’apertura Still Motion. Se amate il funeral doom un po’ più arioso e melodico e meno opprimente, questo è il disco degli Shape of Despair che fa per voi.
NAV’ – Chertogi Smerti
Griffar: Il 2004 è l’anno dell’esordio sulla lunga distanza dei Навь (Nav’), elementi di spicco della scena di Murmansk della quale già accennai l’anno passato in occasione del loro split con gli Old Wainds. Scena che purtroppo è sparita nel nulla con il passare del tempo, ed è un peccato, perché a noi appassionati di black metal glaciale di chicche ne ha regalate non poche. Una di esse è il disco del quale si sta parlando, Chertogi Smerti (la casa della morte, suppergiù) un assalto frontale da 32 minuti di lame di ghiaccio lanciate a tutta velocità che sfianca da quanto si rivela violento e privo di alcun compromesso. Lontani echi di thrash metal sopraggiungono di tanto in tanto, e fa capolino persino qualche linea vocale pulita, ma nel complesso l’opera fa precipitare di svariati gradi la temperatura della stanza nella quale vi trovate durante l’ascolto, e sì, quella che vedete uscire dalle casse dello stereo è proprio neve… A loro nome anche un secondo album uscito nel 2008, un CD che contiene le due demo rimasterizzate e uno split con i Deathmoor uscito nel 2014, dopodiché il silenzio. Risultano nondimeno ancora attivi, ma ci sono poche speranze di poter ascoltare loro nuova musica. Il CD di Chertogi Smerti (uscito per l’intraprendente ma piccolissima Miriquidi productions) si trova su Discogs a pochi spiccioli, segno che in troppo pochi hanno compreso l’effettivo valore dei gruppi di quell’interessantissima realtà oramai perduta.
GREEN DAY – American Idiot
L’Azzeccagarbugli: Nella recensione del debutto degli Arcade Fire parlavo di un altro disco, oggettivamente importante, uscito a settembre 2004 e mi riferivo, ovviamente, ad American Idiot dei Green Day. Lo è perché ha venduto milioni di copie, ha prodotto un numero mostruoso di singoli, ha rilanciato i Green Day, riuscendo a far ottenere loro quel ricambio generazionale di cui non hanno goduto molte band loro coeve e perché, anche a distanza di anni, resta uno dei loro lavori migliori. Già sento un nugolo di proteste sollevarsi: sì, è un disco estremamente commerciale (ma i Green Day lo sono sempre stati), sì, all’epoca alcuni singoli (in particolare Wake Me Up When September Ends) avevano raggiunto un grado di esposizione da farli diventare insopportabili e sì, l’aspetto concettuale è invecchiato e neanche poco. Ma, se prendiamo il disco per quello che è, le sensazioni suscitate all’epoca restano le stesse: American Idiot è l’album in cui i nostri riescono a coniugare al meglio il punk rock degli esordi (il brano omonimo, St. Jimmy), composizioni più pop (Are We Waiting – Boulevard of Broken Dreams) e brani più complessi in cui l’influenza del rock di fine anni ’60 – da sempre presente nei loro dischi – si fa più preponderante, come nella straordinaria e torrenziale Jesus of Suburbia. Che poi American Idiot non sia un capolavoro lo sanno anche i Green Day, ma avercene di album di questo successo che riescono a reggere per un’ora di durata, anche a distanza di vent’anni.
BLOODBATH – Nightmares Made Flesh
Michele Romani: Ad essere sincero non sono uno tra i più grandi fan del progetto Bloodbath e francamente non ho mai capito tutto l’interesse attorno a questa band, nota più per i membri coinvolti che per la musica in sé. Nightmares Made Flesh in ogni caso è quello che viene considerato un po’ all’unisono il migliore parto degli svedesi, che in questo frangente subiscono importanti cambi di formazione all’interno. Alla voce innanzitutto non c’è più Åkerfeldt (uscito di sua volontà per mancanza di motivazione), rimpiazzato da un Peter Tägtgren autore di una prova a dir poco superlativa, con Dan Swäno, più a suo agio nel ruolo di chitarrista, che lascia il posto dietro le pelli a Martin Axenrot (Nifelheim, Witchery e una miriade di altri gruppi), e le due menti dei Katatonia a mantenere inalterato il proprio ruolo. Il disco in effetti è molto più convincente rispetto al troppo acerbo predecessore, il suono è il solito tributo agli Autopsy e alla vecchia scena death metal svedese, ma il tutto suonato con più convinzione, con più varietà, con una produzione migliore e soprattutto con una serie di brani di livello, tra tutti Eaten e Brave New Hell, dal tiro pazzesco. Nulla da tramandare ai posteri, per carità, anche perché trattasi di materiale sentito e risentito, ma non potrà non piacere a tutti i nostalgici del genere.
BLACK FLAME – Torment and Glory
Griffar: E fu così che nel settembre 2003 i collinari torinesi Black Flame realizzarono il disco che vale un’intera carriera. Sì, perché, se mi chiedeste di consigliarvene uno solo, non esiterei ad indicare The Third Revelation, il loro disco più “norvegese”. Fog alle pelli è un mastino assetato di sangue, il Cardinale oltre a sfibrare la sua sei corde con riff taglienti come il logo degli Obituary sfodera una prestazione alla voce degna dell’Aldrahan più ispirato. Funziona tutto, i pezzi sono tutti assassini, non c’è altro da aggiungere. Come dite? “Ma non è di Torment and Glory che dovresti parlare?”. Avete ragione, ma con tutto il bene che gli voglio, e trascurando il fatto che a me i loro dischi piacciono comunque tutti, Torment and Glory a The Third Revelation non si avvicina neanche alla lontana. Ed essendone l’immediato successore la differenza risulta persino più evidente. Questo non gli impedisce di annoverare comunque almeno due staffilate di assoluto pregio (From Ashes I’ll Reborn e My World My Purgatory), ma nel complesso ci sono cali di tensione che nel precedente neanche si sfioravano. Il songwriting è più sofisticato e la padronanza degli strumenti migliorata, ma manca quella rabbia totale che prima abbondava. La band è ancora attiva anche se ha diradato di molto la sua presenza negli scaffali dei negozi: appena due full dal 2015 ad oggi, entrambi con sfumature più riconducibili ad un comunque ottimo death metal d’antan ibridato con del sano black vecchio stile.
W.A.S.P. – The Neon God Part 2 – The Demise
Stefano Mazza: Gli W.A.S.P. sono sempre stati qualcosa di non immediato da definire: superficialmente li si vede come un gruppo glam, hair metal, qualcosa che a che fare con Alice Cooper, i Twisted Sister e i Kiss, perché c’è indubbiamente anche questo e lo hanno saputo fare egregiamente, dato che hanno composto alcune delle migliori canzoni del genere. Già dai tempi di The Headless Children (1989) superarono i confini del canone shock-glam, sempre mantenendosi coerenti con il loro stile e con The Crimson Idol (1992) Blackie Lawless dimostrò di saper pensare davvero in grande con una metal opera di alto livello. The Neon God è un’altra metal opera, lunga tanto da uscire in due parti a distanza di sei mesi l’una dall’altra, ed è una specie di monumento allo stile degli W.A.S.P. La seconda parte, The Demise, è quella maggiormente riuscita, con meno intermezzi e con brani più convincenti e meglio concepiti. Lo stile è sempre lo stesso, le idee sono ottime e funzionano, quindi l’ascolto scorre bene, ma quello che colpisce su tutto è la voce di Blackie che sentiamo al massimo dello splendore, molto appassionata, potente e usata in vari registri, quando serve. Tutto questo a quarantotto anni, dopo vent’anni di carriera. Un grande gruppo, e uno dei migliori dischi della loro discografia.
NYKTALGIA – st
Michele Romani: Nonostante appena due dischi pubblicati, i Nyktalgia si sono assicurati un posto di tutto rispetto nel gotha del suicidal/depressive black metal più disperato e lancinante, e il fatto che un’etichetta storica come la No Colours abbia voluto metterli sotto contratto è sinonimo di assoluta garanzia. Tutto questo è durato fino al 2008, quando, dopo uno dei loro rarissimi concerti in quel di Trondheim, la band si dichiarò ufficialmente sciolta, lasciando ai posteri due pietre miliari come Peisthanatos e questo esordio autointitolato di cui andiamo a parlare. Fin dalle note inziali di Misere Nobis è chiarissimo l’intento delle menti del progetto, Malfeitor e Winterheart (quest’ultimo factotum anche dei clamorosi Sterbend), ossia infondere nell’ascoltatore la più assoluta tristezza e malinconia, tramite quei riff cadenzati ripetuti allo sfinimento di chiarissima ispirazione burzumiana a cui fanno da contraltare parti più veloci in tipico stile black metal vecchia scuola. La bravura dei Nyktalgia (discorso che si può allargare a tutto il DSBM di estrazione teutonica) è quella di utilizzare riff e melodie relativamente semplici che però ti si stampano in testa sin da subito e non ne vogliono più sapere di andarsene, come ad esempio nella spettacolare Lamento Larmoyant, brano che ricorda moltissimo nella struttura (suono del basso in particolare) gli indimenticabili Forgotten Woods, specialmente quelli di The Curse of Mankind. Per tutti gli amanti del depressive black crucco dei primi anni 2000 questa è una piccola perla nascosta che non può mancare assolutamente nella vostra collezione. Peccato siano durati così poco.
MYSTIC FOREST – Romances
Griffar: L’ultimo bellissimo disco dello sfortunato genio incompreso Stefan Kozak a nome Mystic Forest, quando suonava musica mesta, decadente e strapiena di fascino, debordante di atmosfere prese di peso dal tardo Ottocento parigino e dalla musica classica di Chopin, miscelate con mirabile talento e sapienza con un black metal personale e impostato in prevalenza su velocità disumane – benché sia spesso quando rallenta il metronomo che vengono fuori le cose migliori, vedasi la strabiliante Cette Rose que Tende la Mort. Gli interludi di piano, abitualmente usati come coda delle composizioni, e il costante utilizzo in sottofondo della fisarmonica oltre che quello cospicuo del pianoforte e delle voci femminili, riportano in vita un passato ormai defunto, rintracciabile nei film d’essai francesi in bianco e nero, mentre lo screaming acuto e penetrante di Stefan ci riporta nella modernità, caotica e molto, molto malvagia. È migliorato tecnicamente anche alla chitarra, così da poter proporre assoli e fraseggi vicinissimi alla perfezione. Ascoltando dischi come questo mi rammarico di aver perso un simile artista troppo prematuramente. Romances chiude la prima parte della carriera della band, costituita da quattro imperdibili full dei quali si è già doverosamente parlato. In ghiaccio per otto anni, il ritorno fu votato a un radicale cambio di stile, portandosi in ambienti gothic metal, posizionandosi su livelli a mio parere molto inferiori alla sua carriera 1997-2004. Preconizzante in un certo senso il profondo disagio che ne ispirò il titolo, In the End è il suo disco meno riuscito e quello che più dava indizi sul tragico epilogo di tre anni dopo.
SACRED STEEL – Iron Blessings
Barg: Ai dischi dei Sacred Steel bisogna approcciarsi sempre con un certo timore reverenziale, perché c’è sempre il rischio che dalle casse esca fuori un qualche mercenario barbaro assetato di sangue che ti vuole piantare un’ascia bipenne nel cranio. I Sacred Steel spaccano a priori, diciamo così, qualsiasi cosa facciano: sono troppo cazzuti, bestiali, violenti, aggressivi e primordiali per non subirne il fascino, con quell’atmosfera morbosa e cupa che è precisamente quella dei racconti di Howard più lovecraftiani. Poi nello specifico, com’è ovvio, alcuni album sono usciti meglio di altri. Iron Blessings non è uno dei più memorabili, ma si fa sentire benissimo lo stesso per via dei motivi sopraelencati. Qua c’è uno dei loro pezzi migliori, Victory of Black Steel, una roba che se la mettessero in rotazione radiofonica potrebbe causare vagonate di morti violente per futili motivi: solo per come entra quell’assolo slayeriano meriterebbe di far guadagnare agli autori gloria eterna.



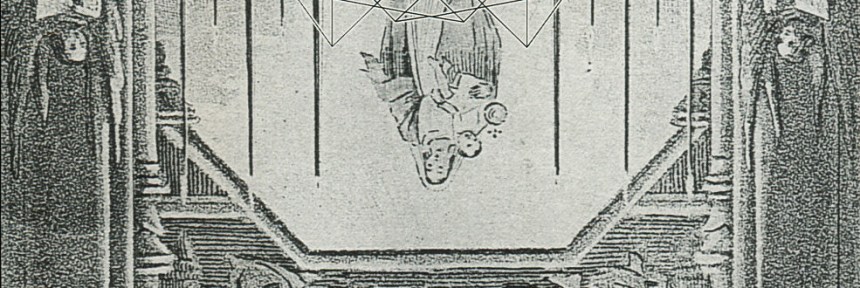


















se non vi emozionate con la title track di Fate of Norns avete un bidone della spazzatura al posto del cuore
"Mi piace"Piace a 3 people
Gli A.A., perlomeno fino a TotTG sono uno dei miei gruppi preferito. Insieme ad un altro gruppo che adoro e di cui non farò il nome sono sovente dileggiati da questa redazione di debosciati, che continuo imperterrito a seguire perchè gli voglio bene.
Anni fa su queste pagine virtuali canzonarono pesantemente One foot in Hell dei Cirith Ungol, poi si sono redenti. Magari accadrà lo stesso con gli Amin Amarth, ma ne dubito.
Comunque vi voglio bene.
Stronzi.
"Mi piace"Piace a 1 persona
È troppo poco trve start from the dark degli Europe?
"Mi piace""Mi piace"
Quanta roba. In sintesi:
"Mi piace"Piace a 2 people
Io a Fate Of Norns resto abbastanza affezionato, sarà perché essendo classe ’89 rientravo nel pieno nel loro target di fanciulli e infatti sono stati una delle primissime scoperte che ho fatto nel magico mondo del metallo. Poi chiaro che una volta scoperti i Bathory di questi non ne vuoi più sentire parlare, però per l’appunto come gateway drug funzionavano benissimo.
Ve la prendete troppo con loro, ok sono una baracconata plasticona e non ci piove, ma non sapete quanti metallini della mia generazione hanno salvato da quel cazzo di metalcore che dominava a metà anni Zero. Voglio dire, avevi tutti quegli emo frangettoni piagnoni e poi arrivavano gli Amon Amarth a portarti sulla strada di Odino e del Valhalla. Di questo gli va dato atto.
"Mi piace"Piace a 1 persona
Gruppo che ho letteralmente consumato fino ai 20 e qualcosa, poi persi quasi completamente per gli ovvi motivi esposti più e più volte.
Concordo col tirare una riga (come direbbe [inserire nome buffo]) dopo TOTTG.
Giovanni Uova e soci da quando hanno visto un po’ di soldi si sono veramente mega seduti sugli allori, però lui è (era?) abbastanza onesto, ricordo una vecchia intervista nella quale rimandava ai Bathory per il “vero” Viking metal ammettendo di essere altro.
Fate of Norns aveva grossomodo metà canzoni buone ma comunque si discostava un po’ dal resto fatto fino ad allora, almeno nei testi e nelle intenzioni, poi da WOOOS in poi tutto ha preso un’altra piega che li ha portati sul piano inclinato verso l’eurospinmetal.
Al compianto Evolution Fest mi hanno gasato come poche altre band viste per la prima volta su un palco, quando ancora non ci si metteva seduti a vogare, Signora mia.
"Mi piace"Piace a 1 persona
Acceleration degli Age Of Silence. Bestie!
"Mi piace""Mi piace"