La mensa di Odino #8
Quanto ho aspettato questo disco non lo potete capire. Avevo innalzato il debutto dei CHARRED WALLS OF THE DAMNED a mio personale disco dell’anno nella playlist del 2010 (vi linkerei il post, ma purtroppo è andato perso). Loro sono praticamente un supergruppo fondato da Richard Christy (che compone tutto), Steve DiGiorgio, Ripper Owens e Jason Suecof. I primi tre non penso abbiano bisogno di presentazioni, il quarto è un produttore di roba di cui non ce ne frega un cazzo. Insomma, il debutto omonimo era un bellissimo esempio di power metal americano moderno: triste, incazzato, violento e lancinante. Il resto lo trovate scritto nella recensione. Questo Cold Winds On Timeless Days lo aspettavo con aspettative altine, voglio dire: quattro personaggi del genere, un debutto folgorante, non è che il secondo disco potrà mai fare così schifo, no? E invece sì, fa proprio schifo. Il primo pezzo era uscito già in autunno, ma era talmente brutto che decisi di non metterlo sul blog, fiducioso poi di poter fare una buona recensione completa una volta uscito il disco. E insomma, le canzoni una alla volta iniziavano a trapelare in streaming, e una alla volta erano tutte tremende. A novembre uscì il disco, ma io avevo ormai fiutato il pacco di merda, e non me la sentii di ascoltarlo subito. È per questo che la recensione esce così tardi, anche se poi una vera recensione non è, visto che l’unica cosa che mi sento di dire è che Cold Winds On Timeless Days è veramente brutto e che fa anche un po’ male al cuore sentire Ripper affannarsi tanto per cantare ste cacate. Un’involuzione tremenda e forse è meglio che non ne parliamo più.
 Poi ci sono i NECRONOMICCON, che sono dei simpatici cazzoni probabilmente americani che coverizzano canzoni famose degli anni ottanta in chiave black metal. Detta così suona male, ma vi assicuro che Hot Dog Cart Hunger è divertente. In copertina hanno Slimer degli Acchiappafantasmi, e l’intro dell’album è proprio il rifacimento del tema del film. Hanno anche fatto un altro disco (che mi procurerò ASAP) chiamato Mjolnir For Nothing. E niente, vi consiglio di ascoltare le loro versioni di mirabolanti pezzi come Careless Whisper di George Michael, Everybody Wants To Rule The World dei Tears For Fears, Eye Of The Tiger dei Survivor e Never Gonna Give You Up dell’eroe internettiano Rick Astley.
Poi ci sono i NECRONOMICCON, che sono dei simpatici cazzoni probabilmente americani che coverizzano canzoni famose degli anni ottanta in chiave black metal. Detta così suona male, ma vi assicuro che Hot Dog Cart Hunger è divertente. In copertina hanno Slimer degli Acchiappafantasmi, e l’intro dell’album è proprio il rifacimento del tema del film. Hanno anche fatto un altro disco (che mi procurerò ASAP) chiamato Mjolnir For Nothing. E niente, vi consiglio di ascoltare le loro versioni di mirabolanti pezzi come Careless Whisper di George Michael, Everybody Wants To Rule The World dei Tears For Fears, Eye Of The Tiger dei Survivor e Never Gonna Give You Up dell’eroe internettiano Rick Astley.
Gli AZAGHAL esistono da tempo immemorabile, sono arrivati al nono disco e in tutti questi anni sono rimasti sempre gli stessi onesti discreti mestieranti. Nemesis non fa eccezione; tipico black finlandese, ortodosso nello stile ma piuttosto pulito nella forma, equamente diviso tra Svezia e Norvegia come influenze, tra i blastbeat e la valorizzazione delle chitarre soliste della prima e il black’n’roll marcio della seconda. Sugli scudi Ex Nihilo, midtempo sulfureo che sembra uscito da La Grande Danse Macabre dei Marduk; Black Legions Of Satan, midtempo puzzone da hangover preso a male con ritornello da canticchiare stile i Satyricon di Volcano; la titletrack, che ricorda quelle cose che uscivano in Svezia nella metà degli anni novanta, tra Dissection e Naglfar; e infine Pohjoisen Valkoinen Kuolema, un pezzo che potrebbero scrivere i Taake attuali. Ora che arriva la primavera questo tipo di black metal è un giusto compromesso.
Un altro tipo di black metal, che non è molto estivo ma più adatto a una sbronza in solitaria di quelle brutte e squallide, è quello che suonano gli PTAHIL, al debutto con For His Satanic Majesty’s Glory. Loro sono americani, e questo si sente parecchio per le loro pesantissime influenze sludge e doom; a tal punto che spesso sembra più di ascoltare un tipico gruppo della scuderia Southern Lord. Le atmosfere sono davvero malate, e il disco potrebbe essere l’ideale colonna sonora per un documentario sul disagio esistenziale tra gli sbandati della gioventù occidentale. Gli scenari che vengono alla mente sono i più squallidi possibili. Ventenni senza più niente da perdere tenuti in vita solo dal loro respiro, accovacciati in un angolo di un lercio squat con la testa tra le ginocchia, lo sguardo vacuo e gli occhi infossati. Scarafaggi, escrementi di ratto e costole spezzate da giorni dopo una rissa tra tossici per rubare una dose di crack. Forse per poter capire sto disco dovrei ridurmi veramente male. Ovviamente non mi ridurrò mai così male, ma non mancherà occasione per fare del mio meglio al netto dei miei borghesissimi limiti; e, se me ne ricorderò e se riuscirò ad arrancare fino al tastino play, riascolterò questo disco e vi dirò. Promesso.
Gli ILLNATH sono danesi e suonano una specie di degenerazione del black melodico, un incrocio tra primi Norther, ultimi Amorphis e Funeris Nocturnum. Detta così sembra chissà cosa ma vi assicuro che sotto sotto è la solita sbobba. 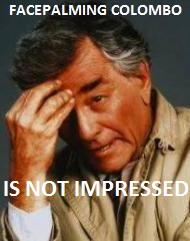 Third Act In The Theatre Of Madness è appunto il terzo disco e io per amor di sincerità devo confessare che gli altri due galattici dischi degli Illnath non li ho ascoltati. È un mondo difficile. Quello prima risaliva al 2006: che poi magari all’epoca erano meglio degli Emperor, che ne sai. Non bisogna però essere ingenerosi con gli Illnath, che qualche pregio alla fine ce l’hanno pure. Elenchiamoli:
Third Act In The Theatre Of Madness è appunto il terzo disco e io per amor di sincerità devo confessare che gli altri due galattici dischi degli Illnath non li ho ascoltati. È un mondo difficile. Quello prima risaliva al 2006: che poi magari all’epoca erano meglio degli Emperor, che ne sai. Non bisogna però essere ingenerosi con gli Illnath, che qualche pregio alla fine ce l’hanno pure. Elenchiamoli:
1.il chitarrista si chiama Peter Falk
2.la cantante (una donna) si chiama MONA BECK, una cosa che farà molto ridere i nostri amici che ci leggono dal Veneto e
3.in giro c’è molto di peggio e qui almeno ci sono le chitarre che fischiano. Comunque niente che riesca a salvare gli iperbolici Illnath e le loro fischianti chitarre dall’ineluttabile destino che li attende nel Dimenticatoio, mitica quarta dimensione spaziotemporale che risiede in ognuno di noi e in cui è molto facile entrare ma da cui è quasi impossibile uscire.
Concludiamo in bellezza con i WOODS OF YPRES, il cui Woods 5: Grey Skies And Electric Lights è di gran lunga il più bel disco tra quelli in esame. Per inquadrarli stilisticamente ci si può immaginare un incrocio tra Edge Of Sanity, Katatonia, Swallow The Sun e Type 0 Negative, tra gli altri. Loro sono canadesi e questo è il loro quinto disco; l’ultimo, dato che David Gold, cantante, chitarrista e membro fondatore (anche nei The Northern Ontario Black Metal Preservation Society), è morto poco tempo dopo la fine delle registrazioni. La cosa che fa rabbrividire è che proprio la morte è al centro del concept lirico dei WOY, e in modo anche abbastanza sentito e non solo come stereotipico accompagnamento al loro gothic doom metal dalle sporadiche reminiscenze black. Morte intesa non solo in senso fisico ma anche come fredda tomba dei sentimenti; morte come vita senza calore; morte come rassegnazione, senso di abbandono, voglia di lasciarsi andare e cedere definitivamente le armi di fronte ad una battaglia che magari potrebbe pure essere vinta, ma a un prezzo troppo alto, e troppo doloroso. Woods 5 è disperante sempre, anche nei momenti più faciloni tipo Career Suicide (Is Not Real Suicide), che starebbe bene nella scaletta di un rock club. Altri pezzi, come le finali Alternate Ending e Finality, sono angoscia allo stato puro, roba che riuscirebbe a battere anche gli status del profilo facebook di Fabrizio ‘Doom’ Socci in hangover durante il quinto giorno di pioggia consecutivo e appena dopo che la Roma ha perso 4-0 con la Lazio. Consigliato a chiunque, a meno che non abbiate seri istinti suicidi e non aspettiate altro che una causa scatenante. (barg)


Pingback: La mensa di Odino #11 « Metal Skunk
Pingback: Playlist 2012 « Metal Skunk